“Sarte pagate una miseria”, il New York Times contro Max Mara e i big della moda
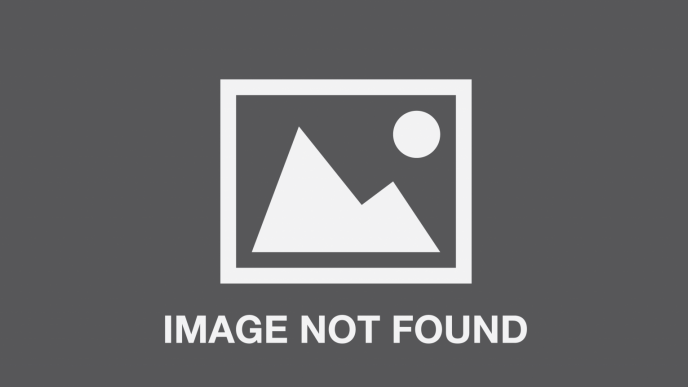
L’inchiesta denuncia paghe da 1 euro l’ora in Puglia e paragona l’Italia a Paesi come la Cina, il Bangladesh, il Vietnam e l’India. Il presidente della Camera della moda Carlo Capasa: “Attacco strumentale e vergognoso”
REGGIO EMILIA – Durissimo reportage del New York Times contro la moda italiana. Si chiede il quotidiano della Grande Mela: l’Italia patria della moda, “ma a quale costo?”. L’inchiesta è sullo sfruttamento della manodopera per la produzione di capi di alta moda “Made in Italy” e tira in ballo grandi marchi come Max Mara, Fendi o Louis Vuitton, che si affidano a lavoratrici e lavoratori sottopagati e senza contratto: l’articolo cita le testimonianze di sarte pugliesi che lavorano in nero, denuncia paghe da 1 euro l’ora e paragona l’Italia a Paesi come la Cina, il Bangladesh, il Vietnam e l’India.
“È una vergogna: un attacco puramente demagogico”, ha commentato il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, promettendo anche battaglia legale. Secondo Capasa non è una casualità che l’articolo sulle ‘ombre’ della moda italiana sia uscito in concomitanza con il ‘green carpet’ che dà ufficialmente il via alla Fashion Week di Milano. “La Puglia non è il Bangladesh”, ha replicato Capasa che tra l’altro è nato a Lecce. “Gli americani rosicano – ha osservato – perché siamo sempre più bravi e avanti nella moda sostenibile”.
Il New York Times parla di “migliaia di persone”, soprattutto donne, che lavorano da casa tessendo “senza contratto né assicurazione” preziosi tessuti da destinare alle grandi firme. Si cita in particolare un piccolo paesino del barese, Santeramo in Colle, dove una donna nel suo appartamento cuce cappotti di lana che vengono venduti ad un prezzo compreso tra gli 800 e i 2000 euro, in cambio di un euro al metro. Il lavoro le è stato affidato da una fabbrica locale, che produce capispalla per altre grandi firme internazionali, da Fendi e Louis Vuitton.
“Il lavoro a domicilio – sostiene il Nyt – è una pietra miliare della catena di distribuzione della cosiddetta fast fashion. È particolarmente diffuso in Paesi come l’India, la Cina, il Bangladesh e il Vietnam, dove milioni di persone, per lo più donne, sono la parte meno protetta dell’intera industria”. Secondo il quotidiano, sebbene le condizioni delle lavoratrici italiane non possano essere assimilate a quelle della manodopera sfruttata in paesi del terzo mondo, i loro salari sì.
Da qualche anno esiste, per il tessile e la pelletteria, una campagna mondiale, Clean Clothes Campaing, con una sezione italiana – campagna Abiti Puliti – che lavora per la sensibilizzazione sui temi del salario dignitoso, la salute e la sicurezza, la trasparenza e il lavoro migranti, oltre a pressione verso imprese e governi.
“Se hanno trovato un reato c’è obbligo di denuncia, perché non l’hanno fatto?” si chiede Capasa, per il quale “i nostri contratti sono tutti a tutela dei lavoratori”. “Quello del New York Times è un attacco strumentale che nasce – dice il presidente di Camera Moda – senza aver fatto una vera indagine. Io sono pugliese e la Puglia non è il Bangladesh. Citano fonti sconosciute e dicono anche che in Italia non abbiamo una legge sul salario minimo e questo è grave: le nostre – sottolinea – sono aziende serie, se i subcontratti hanno fatto delle stupidaggini questo va perseguito, ma condividiamo tutti lo stesso contratto per la tutela dei lavoratori. Se poi volevano demonizzare il lavoro domestico – prosegue – trovo che sia sbagliato, ha un senso purché sia ben pagato”.
 0
0